Un giornalista liberale tra Cavour e Azeglio.
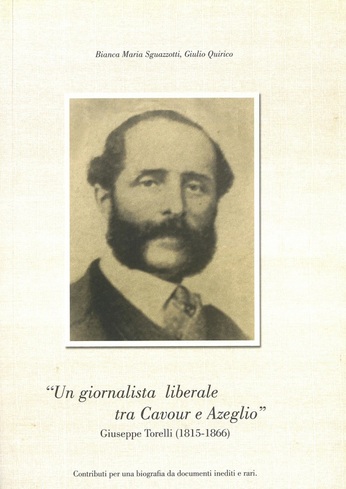 Copertina del libro con volto del Torelli.
Copertina del libro con volto del Torelli. La ricorrenza del bicentenario della nascita di Giuseppe Torelli, 6 dicembre, è ottima e doverosa occasione per ricordare ed approfondire la figura di un novarese ingiustamente poco ricordato che fu scrittore, uomo politico e “giornalista liberale” come i due studiosi novaresi hanno definito nel titolo del loro corposo libro questa poliedrica figura.
Grazie quindi al lavoro certosino di alcuni anni di Bianca Maria Sguazzotti, mai dimenticata insegnante di lettere presso il Liceo Artistico Statale di Novara e di Giulio Quirico, apprezzato docente di filosofia e storia presso il Liceo Scientifico Statale di Arona, disponiamo ora di moltissimi documenti e lettere inedite riguardanti non solo la vita di Torelli, ma intrecciata ad essa, la storia d’Italia del diciannovesimo secolo attraverso le testimonianze dirette di due personaggi che la determinarono. Il libro intitolato appunto “Un giornalista liberale tra Cavour e Azeglio” evidenzia le idee liberali moderate che con essi condivideva attraverso un’idea di “Stato liberal-nazionale”, frutto di integrazione del liberalismo di principio settecentesco con il nazionalismo di visione ottocentesca. L’amore di patria emerge tramite la sua qualità di uomo di ingegno, brillante, dalla penna elegante ed arguta e dall’umorismo raffinato.
Nato a Recetto il 6 dicembre 1815, figlio del medico Antonio, rimasto orfano in tenera età, il Torelli compì i primi studi nel Collegio di Doccio, piccolo centro di fronte a Quarona, una “scuola di curati”, dove erano tenuti a pensione gli studenti a cui veniva insegnato leggere, scrivere e far di conto. Ai sacerdoti che gli impartirono i primi insegnamenti, i fratelli Marco e Gervasio Zanoni, fu sempre molto grato, tanto che nei suoi scritti riconobbe loro il merito della sua formazione morale; in particolare di don Marco scrisse “sacerdote d’alto impegno ed anima santissima … che ricordo sempre con affetto di figlio …”.
Il risultato di quel periodo di permanenza a Doccio fu il romanzo “Ettore Santo” che egli scrisse diciottenne, nel 1834, e che, nonostante siano passati centottanta anni, viene considerato il miglior romanzo autobiografico dell’Ottocento novarese, sia per lo stile sciolto, vivace ed umoristico, sia per la capacità di descrizione dello schema educativo che porta naturalmente ad un confronto con quello attuale. Attraverso lo studio dei vari personaggi, il Torelli esprime la sua interiorità, ma manifesta anche una notevole capacità di descrizione, attraverso pennellate ottocentesche, ad esempio, del paese valsesiano.
Scrive “… Il paese di Sombrio (Doccio) è posto in una deliziosa valle; le sue case sembrano un branco di pecore addormentate vicine ad un fiume, ed il campanile si direbbe ne è il pastore, tutto v’è quieto, la gente vi è religiosa, e gli orologi vanno ancora all’italiana. La chiesa parrocchiale, a cui sta annesso il collegio, è posta proprio sulla sponda del fiume, e poco discosto, un torrente discende dalla montagna a mettervi foce. Innanzi alla chiesa un antichissimo noce sparge all’aria le infinite braccia e nell’estate getta al suolo un’ombra delle più fitte ed amabili; da questa maestosa pianta quasi altrettanti figli partono torreggiando altissimi pioppi disposti in lunga fila da ambo i lati della strada che parte dalla chiesa. Questi pioppi intermezzati da salici producono una bella forma di corridoio; entro il quale se si inoltra il capo, verso mezzodì appare da lunge l’immenso piano lombardo colla sua tinta azzurrina e verso il nord la vista resta chiusa dalla superba giogaia delle Alpi; all’oriente ed all’occidente sonvi le due montagne che formano la vallata; montagne che io studiai pianta per pianta, macchia per macchia delle quali ricordo la figura onde s’improntano nella volta del cielo, la cappella dedicata alla Madonna e quella dedicata a San Giovanni e saprei contare tutti gli scogli sporgenti e fantastici …”.
Dopo Doccio Torelli frequentò il Collegio dei Somaschi a Casale ed il corso di logica e filosofia presso i Gesuiti di Novara. Nel 1836 si laureò in filosofia e medicina presso l’Università di Torino, ma lasciò l’arte di Ippocrate per il giornalismo che esercitò dapprima a Novara, poi a Milano e a Torino, dove su “Il Risorgimento” fondato da Cavour pubblicò con successo le “Lettere politiche” con il “nom de plume” di Ciro d’Arco negli anni 1849-1850. Fu in quell’occasione che Cavour lo definì “apostolo del buon senso”. Da Milano gli Austriaci lo espulsero nel 1848, ai primi passi dell’insurrezione lombarda, ma vi tornò chiamato dal governo provvisorio per redigere la Gazzetta Ufficiale “Il 22 Marzo”. Ritornato il potere austriaco in Lombardia, lasciò Milano per Genova dapprima e Parigi poi, dove rimase alcuni mesi difendendo strenuamente la causa italiana dagli attacchi della stampa francese.
Sincero amico di Cavour e Azeglio, fu con questi al governo di Milano e Bologna; sedette per alcune legislature nella Camera dei Deputati e quando Cavour fu eletto Ministro, lo sostituì nella direzione de “Il Risorgimento”. Torelli studiò profondamente il conte di Cavour e così lo descrisse in un’occasione: “Aveva in quell’epoca un viso fresco fresco, lievemente irrorato alle guance da un color rosa che più tardi doveva mutarsi in gialliccio dorato. Aveva gli occhi sì vivaci e pieni di tanti e così variamenti, che era malagevole fissarne il carattere permanente … Teneva nei modi il garbo aristocratico, ma privo affatto di volgari pretensioni: il più spesso parlava a mezzo labbro, e ascoltava con urbana attenzione l’interlocutore, qualunque ci si fosse: qualità questa che conservò sempre, anche divenuto celebre, anche quando si riservava il diritto di far poi come gli piaceva, escluse, ben inteso, le occasioni di passioni e d’impeto …” Torelli li definiva “gli impeti” e così li descriveva “… Agli angoli esterni della sua bocca fredda e priva d’istinti cominciavano già a spuntare due sottili rughe, le quali dovevano avere per ufficio di svelare i suoi affetti nei momenti di concitazione. E invero, a chi lo ha poi studiato davvicino, niente era più facile che il prevedere i suoi impeti, solo che avesse posto mente al lento raggrinzarsi e tremolare di quelle due rughe ”.
Anche con Massimo Azeglio (non d’Azeglio, così amava farsi chiamare) ebbe una fitta ed interessante corrispondenza che durò fino alla morte, avvenuta per entrambi nel 1866, 15 gennaio per Azeglio ed il 27 aprile per Torelli. In essa si riscontra un’amicizia derivante da una reciproca stima. Numerosi gli apprezzamenti positivi su Torelli che Azeglio ospitò frequentemente con la sua famiglia nella villa di Cannero. Affettuosi erano anche i toni utilizzati, come si evince da uno scritto del 15 giugno 1863: “Chissà che non si faccia una spedizione di casa Torelli al completo; ben inteso che in questo minaccioso caso, si dormirebbe tutti all’albergo di Cannero, debbo pur dire che tanto alla signora Peppina (N.d.R. si stratta di Giuseppina Brambilla, simpatica moglie di Torelli) quanto ai rampolli sorride fieramente l’idea di una gitarella sul lago Maggiore”.
In uno scritto da Torino del 5 luglio 1865 Torelli scrive “Caro Massimo, il duetto che mia moglie ha istituito con me per contare le lodi della benigna e magnanima tua maniera di sopportare le invasioni, non è ancora terminato: di noi due però, è lei che canta di più; in che ti conosco da un pezzo, non faccio che il secondo baritono spertichino. Saprai inoltre che i miei figli hanno fra loro deliberato che anche tu hai una faccia intelligente.” Ed aggiunge “Il diavolo mette la coda nelle nostre faccende finanziarie” confidandogli familiarmente le sue difficoltà economiche.
Purtroppo poco ricordato ultimamente, Torelli ha comunque in Novara una via a lui dedicata nel 1926, che precedentemente portava il nome di “Strada vechia del Torrion Quartara” e che si trova nel Quartiere Sacro Cuore.
Grazie quindi alla meritevole opera dei due professori citati, autori del libro “Un giornalista liberale tra Cavour e Azeglio - Contributi per una biografia da documenti inediti e rari”, si è cercato di rendere attuabile il desiderio di Attilia Torelli, ultima nipote di Giuseppe Torelli, cultrice delle memorie della famiglia.
Una visita alla tomba di Famiglia presso il Cimitero di Novara, arco 112, abbellita da un vaso di crisantemi, conferma che il lavoro e l’intelligenza di questo concittadino è ancora nel cuore di qualche novarese. Un grazie infinito a Bianca Maria Sguazzotti e a Giulio Quirico.
Copyright Riccardo Pezzana Sara
 Feed RSS
Feed RSS




