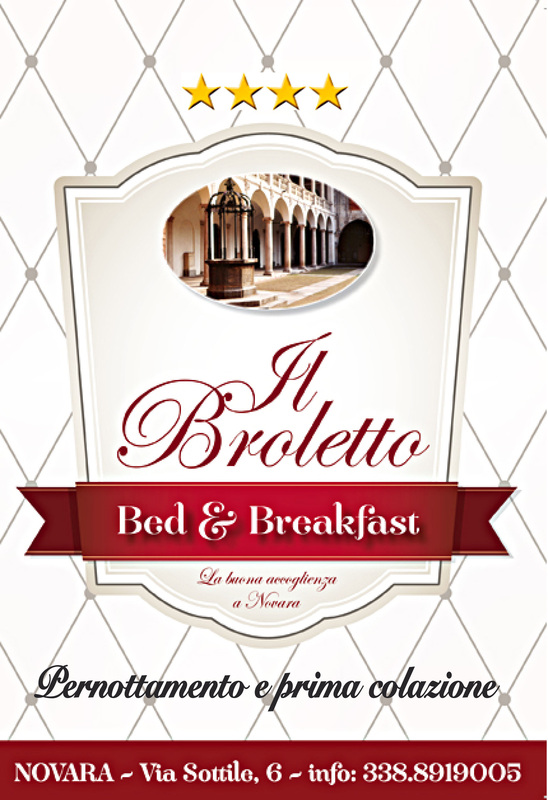Affresco seicentesco raffigurante Santa Lucia
Affresco seicentesco raffigurante Santa Lucia “È la vigilia di Santa Lucia. Sotto le arcate dei portici vi sono tanti banchi illuminati, con ogni sorta di chicchi e Sante Lucie di zuccaro. E tutti i negozi hanno nella bacheca un mondo di belle cose... Quell’anno che eravamo dalla zia abbiamo messo fuori dalla finestra il nostro panierino anche noi, e Santa Lucia ci ha portato la strenna… Chissà che Santa Lucia non passi di qui?... Oh, ci credete bene sciocche!... Fino i bimbi di Novara dicono:
Santa Lucia
Mamma mia
Colla borsa del papà
Santa Lucia la vegnirà”.
È descritta in poche righe la vigilia della festa dedicata a Santa Lucia a Novara; righe appunto tratte dal romanzo “La risaia” della nostra concittadina Maria Antonietta Torriani, ovvero la Marchesa Colombi, ambientato nel mondo delle risaie novaresi. In questa opera, oltre a fare una puntuale denuncia sociale dell’epoca in cui visse, tra il 1840 ed il 1920, la scrittrice ci offre uno spaccato della vita e delle usanze della Novara ottocentesca, di cui fortunatamente ancora esiste qualche traccia.
Molti novaresi ricorderanno, forse con un po’ di nostalgia, quando, bambini, in questa ricorrenza ricevevano un piccolo regalo nel giorno di Santa Lucia, anche se privati della sorpresa di trovarlo nel panierino posto sul davanzale della finestra.
Indubbiamente col passare degli anni sono cambiati i comportamenti, i consumi ed i gusti; neppure l’atmosfera di attesa e di sogno è rimasta la stessa, ma certo è che in molti novaresi sia rimasta la tradizione di raggiungere la chiesa di Santa Lucia, raramente aperta e quasi dimenticata durante tutto l’anno. Solo in quel giorno magico dedicato alla Santa, il 13 dicembre, la chiesa sembra rivivere, risplendente di luci e di preghiere della gente devota.
È un evento che anticipa il Natale, una tradizione di origini contadine che si tramanda e che troviamo anche in altre zone d’Italia.
La festa, prima del 1582, rispettando il calendario giuliano, cadeva in prossimità del solstizio d’inverno, da cui il detto "Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”. Con l’adozione del calendario gregoriano il solstizio si spostava di circa dieci giorni rispetto a quello giuliano.
Erano giorni in cui presso i greci veniva festeggiata la luce; il culto stesso di Santa Lucia richiama quello di Artemide, che, oltre ad essere la dea della caccia e dei parti lo era anche della luce.
In questo ruolo presso i romani era chiamata “Diana Lucifera” e veniva spesso rappresentata sulle monete mentre stringeva tra le mani una o due torce accese. Del resto anche il nome “Lucia” richiama la “lux” latina, per cui è stata adottata come patrona dai ciechi e dagli oculisti.
La vergine e martire Lucia da Siracusa, una delle figure più care alla devozione cristiana, visse a Siracusa e pare sia morta sotto la persecuzione di Diocleziano, intorno al 304 d.C.
Il suo corpo fu conservato a Venezia nella chiesa che portava il suo nome e che fu distrutta per lasciare spazio alla costruzione della Stazione Ferroviaria; i suoi resti mortali furono quindi trasportati nella chiesa di San Geremia nel sestiere di Cannaregio, dedicata anche alla Santa.


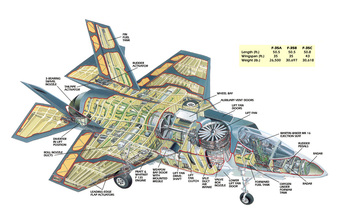



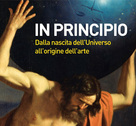








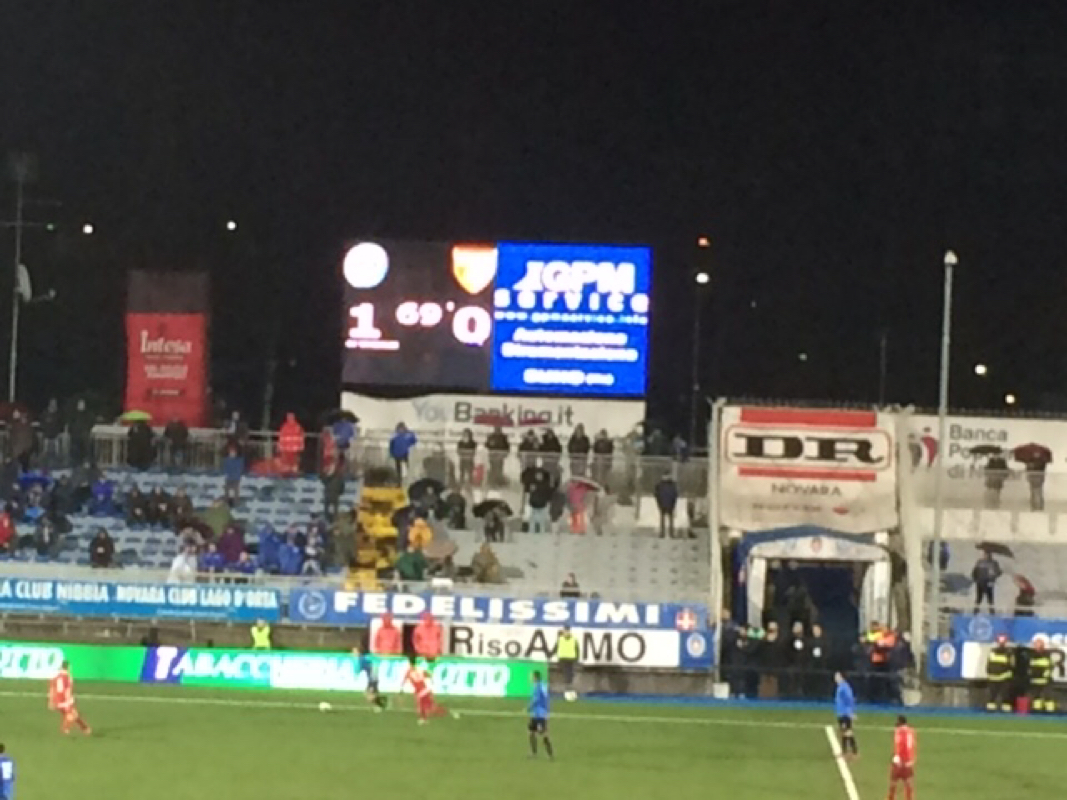












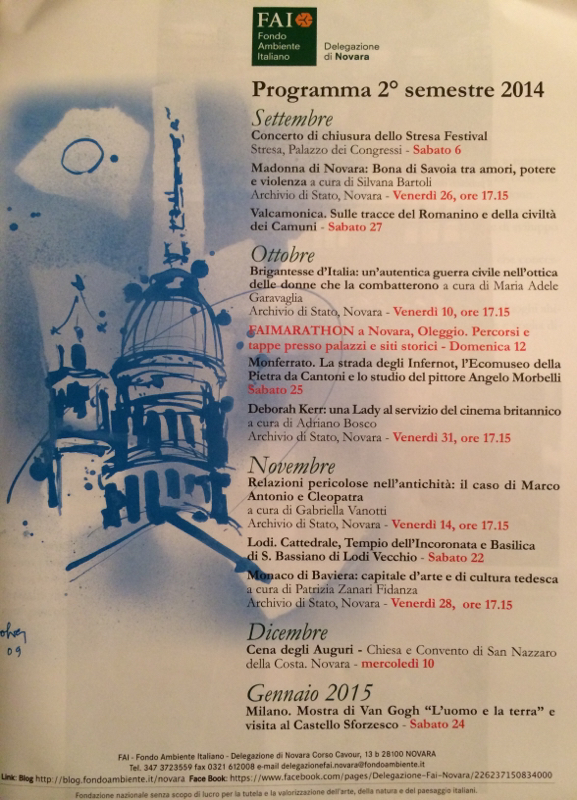
 Feed RSS
Feed RSS